Alzi la mano chi non si è mai chiesto se le proprie scelte siano davvero libere. È una domanda che accompagna l’umanità da millenni, ma solo negli ultimi decenni la neuroscienza ha iniziato a fornire risposte concrete – e a volte spiazzanti. Quello che è emerso dalle ricerche è un quadro complesso che mette in discussione le nostre intuizioni più radicate sulla volontà e sul controllo che esercitiamo sulle nostre azioni.
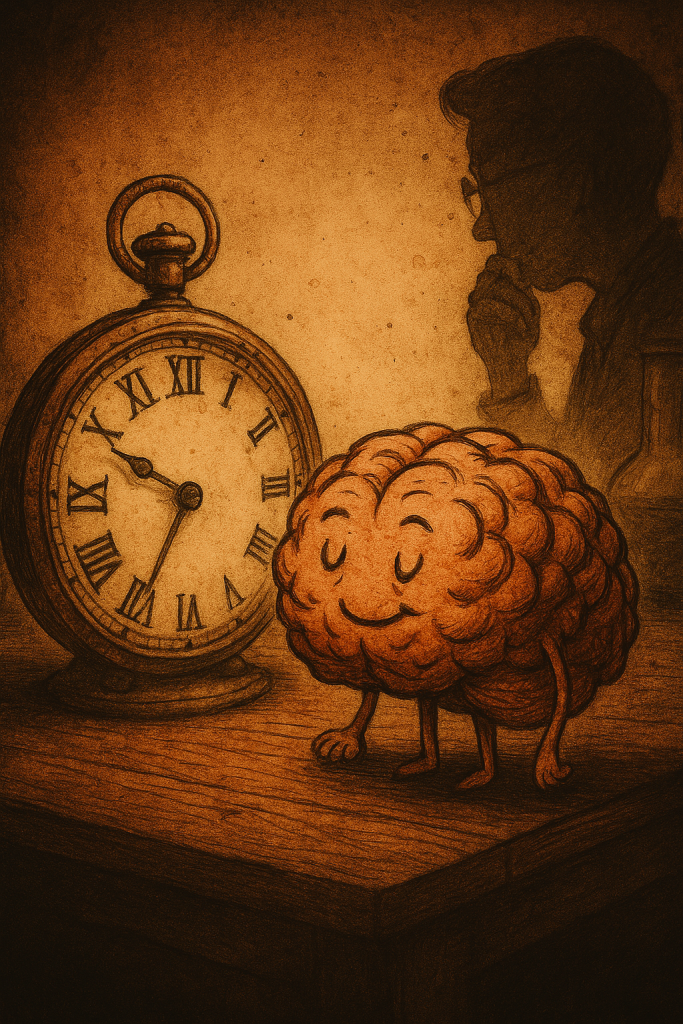
L’esperimento che ha cambiato tutto
Era il 1983 quando Benjamin Libet, neuroscienziato dell’Università della California, pubblicò uno studio destinato a scatenare decenni di dibattiti. L’esperimento sembrava semplice: alcuni volontari sedevano davanti a un oscilloscopio mentre elettrodi posizionati sul cranio registravano la loro attività cerebrale. Il compito? Muovere spontaneamente la mano destra quando ne sentivano l’impulso, osservando nel frattempo un orologio speciale per segnalare il momento esatto in cui avevano “deciso” di muoversi.
I risultati furono sconcertanti. L’attività cerebrale – in particolare quello che Libet chiamò “potenziale di prontezza” (readiness potential) – iniziava a intensificarsi nella corteccia motoria ben 300-400 millisecondi prima che i partecipanti riferissero coscientemente l’intenzione di muoversi. In altre parole, il cervello sembrava “sapere” della decisione prima della coscienza stessa.
La scoperta ebbe l’effetto di una bomba nel mondo accademico. Se il cervello decide prima di noi, cosa resta del libero arbitrio? Siamo davvero gli autori delle nostre scelte o solo spettatori di un copione già scritto dalla biochimica neurale?
Il libero arbitrio sotto processo
Libet stesso fu il primo a rendersi conto delle implicazioni filosofiche del suo lavoro. Tuttavia, non si arrese completamente all’idea di un determinismo neurologico assoluto. Propose invece una soluzione di compromesso: la coscienza, pur non iniziando l’azione, mantiene un “diritto di veto” – una sorta di freno d’emergenza capace di bloccare movimenti già innescati dal cervello inconscio.
Questa teoria del “libero non-fare” divenne rapidamente popolare, ma non placò le controversie. Negli anni successivi, filosofi, neuroscienziati e persino giuristi iniziarono a interrogarsi sulle implicazioni pratiche di queste scoperte. Se le nostre azioni sono guidate da processi inconsci, come possiamo parlare di responsabilità morale e penale?
Quando il rumore diventa decisione
Per fortuna della nostra dignità umana, la storia non finisce qui. Nel 2017, un gruppo di ricercatori guidato da Aaron Schurger ha proposto un’interpretazione radicalmente diversa dei risultati di Libet. Secondo questa nuova teoria, il potenziale di prontezza non rappresenta affatto una “decisione” presa dal cervello inconscio.
Piuttosto, rifletterebbe un fenomeno molto più prosaico: l’accumulo casuale di “rumore neurale” – piccole fluttuazioni elettriche che avvengono continuamente nel nostro sistema nervoso. Quando questo rumore raggiunge una soglia critica, scatena il movimento. È come se il nostro cervello fosse una pentola sul fuoco: quando la pressione interna supera un certo livello, il coperchio salta.
Questa reinterpretazione cambia tutto. Il cervello non “decide” in anticipo, ma genera fluttuazioni casuali che, in determinate condizioni, si trasformano in azione. Siamo passati da un modello deterministico (“il cervello sa già tutto”) a uno probabilistico (“il cervello naviga nell’incertezza come tutti noi”).
Gli strumenti contano: il problema dell’orologio di Libet
Ma le critiche all’esperimento originale non si sono fermate alla reinterpretazione dei dati. Alcuni ricercatori hanno messo sotto la lente d’ingrandimento gli strumenti stessi utilizzati da Libet, in particolare il famoso “orologio” – un quadrante con una lancetta che ruotava rapidamente e che i soggetti dovevano usare per stimare il momento della loro decisione.
Nel 2022, un team guidato da Ivanof ha dimostrato che la velocità e la struttura visiva di questo orologio possono influenzare significativamente la percezione soggettiva del “momento della decisione”. In parole povere, parte della discrepanza temporale osservata da Libet potrebbe dipendere da come funziona il nostro sistema percettivo, piuttosto che da misteriosi processi decisionali inconsci.
È un po’ come scoprire che un orologio segnava l’ora sbagliata e aver basato su quello tutte le proprie teorie sulla puntualità.
Non tutte le decisioni sono uguali
Un’altra rivoluzione è arrivata distinguendo tra tipi diversi di decisioni. Nel 2019, Uri Maoz e il suo team hanno fatto una scoperta illuminante: il potenziale di prontezza emerge chiaramente solo nelle decisioni arbitrarie – quelle prive di significato reale, come scegliere casualmente quale mano muovere in un esperimento di laboratorio.
Quando invece le persone prendono decisioni deliberate e significative – quelle che contano davvero nella vita quotidiana – il readiness potential è molto meno evidente o addirittura assente. Questo significa che il paradigma di Libet, per quanto influente, non può essere generalizzato a tutte le forme di scelta umana.
È la differenza tra decidere se grattarsi il naso e decidere se sposare una persona, cambiare lavoro o avere un figlio. Le prime potrebbero essere guidate da processi automatici, ma per le seconde entriamo in un territorio neurale completamente diverso.
La volontà come processo, non come evento
Le ricerche più recenti stanno dipingendo un quadro ancora più sfumato della volontà umana. Invece di cercare il momento preciso in cui “decidiamo”, i neuroscienziati iniziano a vedere l’intenzione come un processo distribuito nel tempo, che coinvolge attenzione, memoria, predizione e costruzione narrativa del sé.
In questa prospettiva, il libero arbitrio non è un interruttore da accendere o spegnere, ma piuttosto un campo di possibilità che viene continuamente modellato dall’interazione tra cervello, corpo e ambiente. La nostra volontà emerge da dinamiche temporali complesse, non da singoli istanti di decisione.
Il dibattito aperto da Libet continua a essere cruciale ben oltre i confini della ricerca accademica. Le sue implicazioni toccano la neurocriminologia (come giudicare la responsabilità penale?), la pedagogia (come educare al senso di responsabilità?), la bioetica (quando una persona non è più in grado di decidere per sé?) e persino la nostra vita quotidiana.
Se la volontà è davvero il risultato di un processo distribuito e modulabile, allora concetti come responsabilità, intenzionalità e identità personale non possono essere intesi come dati assoluti e immutabili. Diventano invece dinamiche negoziate tra cervello, contesto sociale e coscienza individuale.
Il cervello che ci sorprende ancora
Forse la lezione più importante che possiamo trarre da quattro decenni di ricerche post-Libet è questa: il nostro cervello continua a sorprenderci, obbligandoci a rimettere in discussione certezze che credevamo granitiche. Non siamo né marionette biologiche né dei onnipotenti delle nostre scelte.
Siamo qualcosa di più interessante: esseri consapevoli che navigano in un mare di processi neurali complessi, alcuni consci e altri no, alcuni controllabili e altri meno. La nostra libertà non sta nel controllo assoluto, ma nella capacità di riflettere, modulare e orientare questi processi verso obiettivi che riteniamo significativi.
In fondo, forse non è poi così male scoprire che la realtà è più complessa e affascinante di quanto pensassimo. Il libero arbitrio potrebbe non essere quello che credevamo, ma questo non lo rende meno prezioso. Anzi, forse lo rende più umano.
Riferimenti bibliografici
Ivanoff, J., Branning, P., & Marois, R. (2022). The subjective onset of intention depends on the temporal structure of the Libet clock. Scientific Reports, 12(1), 19030. https://doi.org/10.1038/s41598-022-23513-1
Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 106(3), 623-642. https://doi.org/10.1093/brain/106.3.623
Maoz, U., Mudrik, L., Rivlin, R., Ross, I., Mamelak, A., & Yaffe, G. (2019). Neural precursors of decisions that matter—an ECoG study of deliberate and arbitrary choice. eLife, 8, e39787. https://doi.org/10.7554/eLife.39787
Schurger, A., & Sitt, J. D. (2017). An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(48), E10432-E10441. https://doi.org/10.1073/pnas.1210467109
Liberati, A.S. (2023). Manuale di Neurocriminologia. Editore: DirittoPiù, pp. 380. ISBN: 979-12-80440-26-6 https://forensicscience.academy/product/manuale-neurocriminologia/
