Il contributo delle ricerche di neuroscienze e genetica comportamentale in ambito forense ha scatenato negli ultimi decenni un intenso dibattito riguardo alla fattibilità e alla ammissibilità all’interno del processo penale, delle analisi bio-genetiche per la disamina dell’imputabilità degli autori di reato violento; e non da meno, sulle inevitabili implicazioni etiche e morali di questo stesso utilizzo. La recente ricerca scientifica ha portato, e sta continuando a fornire, ineluttabili evidenze in riferimento al ruolo di specifiche varianti geniche associate ad un sensibile aumento del rischio che i loro portatori si impegnino in condotte aggressive, antisociali e violente e di conseguenza, siano più inclini a commettere crimini e atti dolosi. A questo proposito la ricerca si è posta l’obiettivo di indagare con maggiore attenzione i fini meccanismi attraverso cui agiscono i cosiddetti “geni candidati”, ovvero quei geni preposti alla codifica di enzimi essenziali per il metabolismo, trasporto e ricezione dei neurotrasmettitori (dopamina e serotonina in primis), che, come è noto, sono fondamentali per la regolazione del comportamento umano e sono dunque considerati, a ragione, degli ottimi “sospettati” in materia di propensione individuale alla condotta criminale. Ma anche le complesse interazioni tra geni e ambiente stanno guadagnando un crescente interesse, dal momento che anch’esse, in determinate combinazioni, possono favorire l’emergere di condotte antisociali, oltre che provocare cambiamenti epigenetici ereditabili anche dalla progenie.
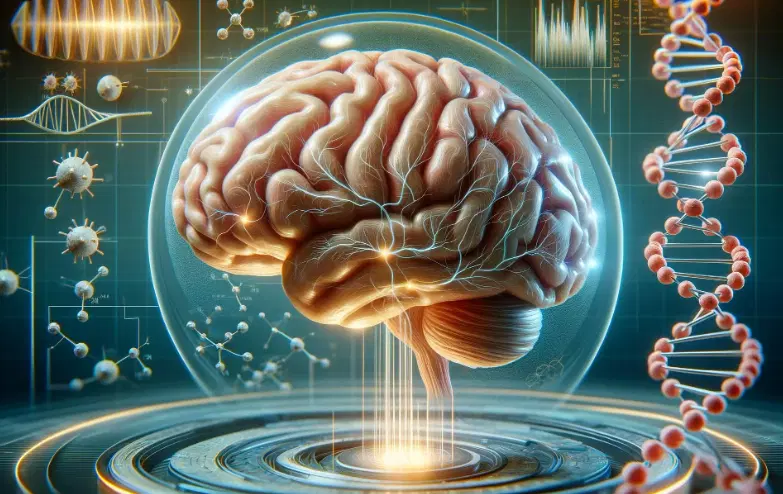
A onor del vero, già alla fine del XIX secolo in Europa era molto popolare l’assunto Lombrosiano secondo il quale alcuni individui fossero geneticamente inclini a delinquere. Secondo il medico e antropologo veronese, infatti, “i criminali non delinquono per un atto cosciente di volontà malvagia” (1876) ma a causa di una predeterminazione biologica – ed ereditabile – individuabile per la presenza, nell’individuo, di specifiche caratteristiche fisiologiche come ad esempio l’attaccatura bassa dei capelli, gli occhi piccoli e ravvicinati, la mascella prominente etc. Per tale motivo la ricerca dell’epoca si basava soprattutto sulla costruzione di alberi genealogici per lo studio dell’ereditabilità di determinati tratti e geni considerati associati alla delinquenza, e per monitorare il mantenimento dei “tratti delinquenti” all’interno di alcune famiglie. Con l’avanzare del tempo e delle conoscenze, si è passati poi a studi più prettamente cromosomici (in particolare riferiti a sindromi e alterazioni genetiche, come le sindromi di Turner, Klinefelter e trisomia-47) e statistici (volti a mettere in relazione di causa-effetto la presenza di tali sindromi con la propensione al crimine).
Più recentemente invece, sono stati gli studi sui gemelli mono- e di-zigoti, e su soggetti adottati a fornire evidenze interessanti per quanto riguarda le relazioni genetica-ambiente. Tali osservazioni infatti, offrono situazioni sperimentali “spontanee” in quanto si raffronta la presenza di uno specifico tratto in individui che condividono quasi tutto – o parte – del proprio patrimonio genetico ma che non sempre condividono lo stesso ambiente familiare e sociale. Ciò consente di stimare non solo gli effetti della biologia, ma anche delle influenze esterne sulla condotta. Ad esempio, quando un bambino, nonostante sia cresciuto in un ambiente con il quale non ha alcuna connessione genetica, finisce per somigliare più ai genitori biologici che a quelli adottivi, allora ci sono pochi dubbi sul fatto che vi sia una predominanza genetica sull’espressione del fenotipo comportamentale del bambino stesso, rispetto all’ambiente. Studi condotti su gemelli monozigoti separati alla nascita e adottati da famiglie differenti (Baron-Cohen, 2011) dimostrano che, in condizioni ambientali “idonee”, coloro che possiedono un patrimonio genetico capace di predisporli a disfunzioni psicopatologiche (es. disturbi di personalità, psicopatia etc.), hanno maggiori probabilità di sviluppare effettivamente tali patologie.
Sebbene, tuttavia, nessuno abbia ancora potuto dimostrare l’esistenza di un effetto puramente deterministicodei geni sul comportamento -giacché non è mai stata riscontrata alcuna variante allelica la cui presenza implichi inevitabilmente l’espressione del fenotipo ad essa associato- la letteratura sostiene in linea generale che le influenze genetiche contribuiscono ad una percentuale di varianza del comportamento violento e antisociale stimate tra il 40 ed il 65% (Rhee & Waldman, 2002), un dato quindi, piuttosto significativo.
Ciò nonostante, è opportuno non sottovalutare il fatto che geni e fattori ambientali si influenzano e si modificano vicendevolmente, sicché individuarne i reciproci effetti specifici è tutt’altro che semplice. Inoltre, se da un lato è stato ampiamente dimostrato come la presenza di determinati geni sia in grado di influenzare la predisposizione individuale al temperamento violento e antisociale, dall’altro queste stesse condotte possono, a loro volta, condizionare la distribuzione di quegli specifici alleli all’interno della popolazione. Infatti, gli individui dalla condotta deviante tendono spesso ad essere sessualmente promiscui, di conseguenza vi sono alte probabilità che essi disperdano il proprio patrimonio genetico nella popolazione, comprensivo di quei geni che potrebbero predisporre al “fenotipo comportamentale criminale”.
In conclusione, non vi è alcun dubbio che i geni e le loro varianti alleliche siano fondamentali nella modulazione della condotta umana (quella normale quanto quella patologica) e, di conseguenza, anche del comportamento criminale. Tuttavia, è altrettanto indubbio che non sia affatto pensabile di poter imputare esclusivamente alla genetica individuale la responsabilità della commissione dell’atto doloso da parte del reo. Invero, le caratteristiche della complessità dell’agire umano sono sempre da riscontrarsi nell’imprescindibile intreccio dei fattori genetici con quelli sociali e ambientali, i quali, dal canto loro, agiscono come spinte, fattori di innesco e suscettibilità personale.
Pertanto le evidenze apportate dalle neuroscienze comportamentali possono, e dovrebbero, essere ammesse in sede forense con l’obiettivo di raggiungere una più chiara comprensione e descrizione del quadro psicopatologico complessivo di un soggetto violento e/o autore di reato. Ciò nonostante tali evidenze non possono fornire, di per sé stesse, elementi sufficienti per la valutazione dell’imputabilità, né della pericolosità sociale del reo, questioni che invece debbono essere stabilite esclusivamente caso per caso e seguendo rigorosamente un approccio multisistemico e multidisciplinare.
Riferimenti bibliografici
Baron-Cohen, S. (2011). La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà. Milano: Raffaello Cortina, ristampa 2020, pp. 221
Liberati, A.S. (2021). I segreti del cervello violento. Un’analisi integrata tra neurocriminologia, genetica e ambiente. Self published on Amazon. ISBN 9798511578415
Lombroso, C. (1876). L’uomo delinquente. Torino, F.lli Brocca.
Miles, D.R. & Carey, G. (1997). Genetic and environmental architecture of human aggression. In J Pers Soc Psychol 72, pp. 207-217
Rhee, S.H. & Waldman, I.D. (2002). Genetic and environmental influences on antisocial behavior: a meta-analysis of twin and adoption studies. In Psychol Bull 128, pp. 490-529
